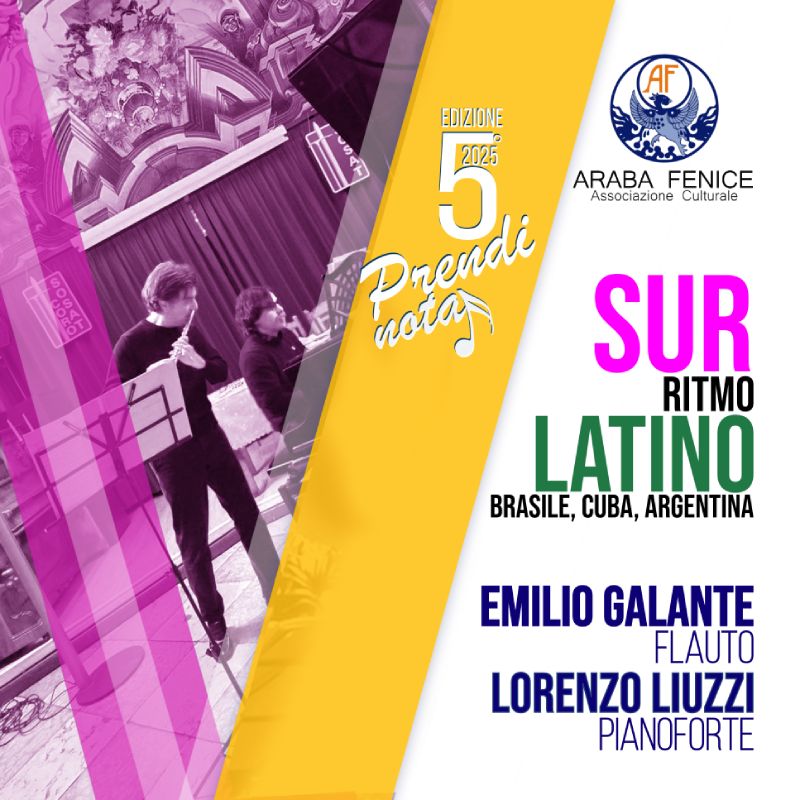La storia moderna di Terni è connessa allo sviluppo industriale che l’Italia ha promosso alla fine del ‘900 ed è strettamente legata alla “fabbrica” per eccellenza del territorio che, fondata nel 1884, con il nome di “Società degli altiforni, fonderie e acciaierie di Terni (SAFAT)”, cambiando diverse ragioni sociali, è arrivata ai giorni nostri come Acciai Speciali Terni S.p.A. Il dato fondamentale è che nel corso degli anni la proprietà del sito industriale è passata dallo Stato ai privati, Thyssen Krupp prima e attualmente Arvedi. Questo fatto ineludibile, ci riporta al biennio 1992-1994, quando l’Italia, a partire dal 16 settembre del 1992 (il famigerato mercoledì nero), finì sotto attacco di speculazioni finanziarie spalleggiate da potenze estere, le quali provocarono collateralmente una rivoluzione economica, sociale e giudiziaria, ormai acclarata dalle cronache e dagli storici. Fummo preda e ci impoverirono per sempre, con la cessione di aziende strategiche come le Autostrade, la Telecom, la Cirio, le banche nazionali e tra esse le acciaierie di Terni. Nessuna motivazione logica può giustificare quella che fu un’operazione sciagurata, dannosa e gravemente lesiva del patrimonio collettivo, poiché un amministratore pubblico, a mio fondato parere, non dovrebbe disporre a proprio piacimento di beni che non gli appartengono e che sono in realtà di proprietà dei suoi amministrati, ovvero dei cittadini, i quali, a norma dell’art.1 della Costituzione, esercitano la Sovranità Popolare. Tuttavia, dobbiamo confrontarci con la realtà, non con quella che ci piacerebbe che fosse, bensì con quella che è, ed essa ci impone di prendere atto che le acciaierie di Terni, ad oggi, sono private e nelle mani del Gruppo Arvedi. Il processo nefasto di svendita di asset fondamentali e la progressiva deindustrializzazione, legata alla scelta di rinunciare a energia a basso costo, come quella nucleare, ha portato a una crisi dell’acciaio che procede a fasi alterne, ma che è strettamente legata agli oneri energetici e della mano d’opera, sui quali la possibilità di contrazione è ridotta, per ragioni ambientali e sociali. Per tali fatti, certamente concreti, il Gruppo Arvedi, per bocca del suo Amministratore Delegato, Dimitri Menecali, ha recentemente dichiarato che non intende firmare il famoso ”accordo di programma”, se non viene abbassato il costo dell’energia necessaria per produrre. Si tratta di una posizione comprensibile ma non giustificabile, soprattutto nelle forme in cui è stata posta, perché ha un vago eco ricattatorio per le conseguenze che lascia intravedere. L’accordo di programma, per chi non lo sapesse, è una complessa convenzione per la quale, a fronte di notevoli finanziamenti pubblici, la proprietà delle acciaierie ternane s’impegna ad investire a sua volta per modernizzare gli impianti e abbattere in maniera significativa le emissioni inquinanti. Ed ecco i punti cruciali della vicenda: Arvedi, quando subentrò alla proprietà tedesca, ben sapeva che uno dei suoi problemi imprenditoriali sarebbe stato l’elevato costo energetico, nonostante che, qualcuno, informalmente e improvvidamente, all’epoca, probabilmente gli promise interessamenti nel senso. Interventi che sono impraticabili a livello istituzionale locale e forse anche nazionale, per i noti vincoli comunitari e non ultimo per una questione di equità, poiché non si può ipotizzare un costo dell’energia per le imprese a prezzi inferiori di quelli praticati ai normali cittadini. In parallelo, tuttavia, le istituzioni locali, si trovano strette da due problemi cruciali. In sostanza, continuare a chiudere ben più di un occhio di fronte a evidenze sanitarie che puntano il dito sulle emissioni inquinanti della fabbrica e accettare i suoi diktat, ovvero, o fate come diciamo noi, oppure chiudiamo (ma non del tutto, per evitare l’onere della bonifica) e vi lasciamo il problema sociale di migliaia di dipendenti senza lavoro e con una bomba sociale pronta ad esplodere. Ebbene, prima di tutto, occorre fare capire all’attuale proprietà che l’impresa, soprattutto a grandi dimensioni, non è disgiunta da responsabilità etiche e che non corrisponde al vero che le Istituzioni non possiedono leve adeguate per indurre a comportamenti più consoni. Terni e il suo comprensorio, hanno ricevuto molto dalla fabbrica ma hanno anche pagato prezzi altissimi, in qualità e sostenibilità della vita, legittimando aspettative che non possono essere derubricate a pretese peregrine. Arvedi, valuti la situazione e torni rapidamente al tavolo delle trattative, con un atteggiamento mutato e certamente più costruttivo, poiché diversamente le Istituzioni non potrebbero continuare a rimanere inerti e silenziose. Nel loro complesso, comunale, regionale e nazionale, le Istituzioni devono fare fronte comune e trovare un punto di equilibrio con la proprietà privata, componendo le esigenze non contrapposte di sviluppo economico e ambiente compatibile con la salute e con la vita. Il Comune di Terni, con il Sindaco Bandecchi in prima persona, ha sollevato il problema secondo cui la fabbrica deve produrre, ma non uccidere i cittadini e che la leale collaborazione pubblica con il privato non può consentire pistole puntate alla tempia, quantomeno non aspettandosi che a tali atteggiamenti non si reagisca, applicando le norme di legge in maniera puntuale e doverosa, anche prendendo iniziative rigide. Infine, e anche questo è un merito indiscutibile dell’attuale amministrazione, forse ruvida ma non improvvida, i dati economici e sociali complessivi non sono sfuggiti all’analisi. Negli anni ’60 la fabbrica aveva 15000 dipendenti, ridotti a 9000 quando fu inconsultamente privatizzata, per arrivare agli attuali 2300, un trend che non ispira ad ottimismo, soprattutto se collegato al fatto che la crisi dell’acciaio, che è un prodotto a bassa tecnologia, che non richiede manodopera altamente qualificata (salvo gli acciai speciali), su cui ora incombono anche i dazi dell’amministrazione Trump (che non sono una novità), inducono inesorabilmente a dismissioni e delocalizzazioni. Occorre certamente, fare tutto il possibile per evitare tali esiti, ma è necessario pensare anche a forme di economia parallele e/o alternative, per non farsi trovare impreparati ove dovesse accadere il peggio, ipotesi non probabile, ma certamente possibile, poiché chi ha responsabilità istituzionali, per essere uno statista, non deve pensare alle prossime elezioni, bensì provvedere alle necessità delle prossime generazioni.
venerdì, 16 Gennaio, 2026
- Home
- Cronaca
- Sport
- Politica e sindacale
- Economia
- Sanità
- Cultura
- Ambiente
- Turismo
- Rubriche
- Arte a Terni
- Attualità
- Cinema e spettacolo
- Culture Sotterranee
- Hobby e intrattenimento
- Musica
- Salute e benessere
- Scienza e tecnologia
- Formazione e Lavoro
- Hit Parade
- Home video
- i dvd più noleggiati
- L’arte di cambiare
- La nutrizionista
- La vignetta di Pier
- Papaveri e papere
- Psicologicamente
- Salute e benessere
- Sommelier Umbria
- Tempus Vitae
- Terni Motori
- Un gendarme della memoria
- Unika Burraco
- Unika Burraco e Bridge
- Meteo
- Home
- Cronaca
- Sport
- Politica e sindacale
- Economia
- Sanità
- Cultura
- Ambiente
- Turismo
- Rubriche
- Arte a Terni
- Attualità
- Cinema e spettacolo
- Culture Sotterranee
- Hobby e intrattenimento
- Musica
- Salute e benessere
- Scienza e tecnologia
- Formazione e Lavoro
- Hit Parade
- Home video
- i dvd più noleggiati
- L’arte di cambiare
- La nutrizionista
- La vignetta di Pier
- Papaveri e papere
- Psicologicamente
- Salute e benessere
- Sommelier Umbria
- Tempus Vitae
- Terni Motori
- Un gendarme della memoria
- Unika Burraco
- Unika Burraco e Bridge
- Meteo
I disaccordi di programma sul costo dell’energia
L'intervento di Raffaello Federighi, capo della Segreteria politica del Segretario nazionale di Alternativa Popolare
0
CONDIVISIONI
Chi Siamo
![]()
Terni in Rete nasce nel Gennaio 2007, come portale cittadino di informazione e di servizi.
Terni in Rete – On Web
Villaggio Achille Grandi, 20
05100 Terni (TR)
P.IVA 01417770557
Contatti (+39) 335 7015948
Testata giornalistica Reg. Trib. di Terni il 05/06/09 al nr. 905 N. 07/09 – Direttore Responsabile: Marcello Guerrieri
Categorie
- Altri sport
- Ambiente
- Ambiente e turismo
- Arte
- Arte a Terni
- Arte a Terni
- Arte e cultura
- Articoli recenti
- Atletica
- Attualità
- Attualità
- BASKET
- Calcio
- CALCIO a 5
- Cinema e spettacolo
- Cinema e spettacolo
- Cronaca
- Cronaca di Amelia
- cronaca di narni
- Cronaca di Narni
- Cronaca di Orvieto
- Cronaca di Terni
- Cronaca di Terni
- Cronaca Umbria
- cronaca umbria
- Cultura
- Culture Sotterranee
- Dal Mondo
- Dall'Italia
- Diocesi TNA
- Economia
- Economia e sindacale
- Eventi
- Eventi e fiere
- Fiere
- Formazione e Lavoro
- Hit Parade
- Hit Parade
- Hobby e intrattenimento
- Home video
- Home video
- i dvd più noleggiati
- i dvd più noleggiati
- In apertura
- In evidenza
- L'arte di cambiare
- L'arte di cambiare
- La nutrizionista
- La vignetta di Pier
- La vignetta di Pier
- Marketing
- MOTOCICLISMO
- Musica
- Musica
- Musica e concerti
- News
- Notizie di Terni
- Papaveri e papere
- Politica
- Politica e sindacale
- Psicologicamente
- Rubriche
- Salute e benessere
- Salute e benessere
- Sanità
- Scienza e tecnologia
- Sommelier Umbria
- Sport
- Teatro
- Tempus Vitae
- Tempus Vitae
- Ternana Calcio
- Terni Motori
- Turismo
- Un gendarme della memoria
- Unika Burraco
- Unika Burraco e Bridge
- Video in evidenza
- Visione Olistica
- Volley
Preferenze privacy
Powered by Meta Digitale